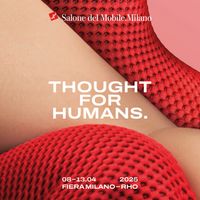in copertina Baia dei Due Frati a Posillipo e Palazzo Donn'Anna a Mergellina
© Photo Courtesy of Francesco Mojo
"È impossibile essere felici nel posto più bello del mondo".
E per Paolo Sorrentino, Napoli è bella come una giovane sirena, di cui tutti sono innamorati ma nessuno se ne prende cura. Parthenope, il suo ultimo film disponibile su Netflix dal 6 febbraio, è una dedica a una città capace di rendere reale l'inverosimile, vestendosi ogni volta di un'anima nuova.
L'attrice Celeste Dalla Porta (da adulta Stefania Sandrelli) - Parthenope, appunto - ci guida in dimore private, piscine scavate nella roccia, ville affacciate sul mare, fino ai quartieri del centro.
Così come ha fatto lei, vogliamo raccontarvi alcuni luoghi della Napoli segreta, quella che si cela tra le ombre del suo barocco monumentale e la polvere del tufo che s'infrange sulle onde del mare. Qui, la bellezza è sospesa tra incompiutezza e opulenza, tra il fascino di architetture che sembrano parlare di un tempo che non è mai davvero arrivato e la magnificenza di un luogo in continuo divenire.
indice dei contenuti
 © Photo Courtesy of Francesco Mojo
© Photo Courtesy of Francesco Mojo
L'«incredibile napoletano» di Sorrentino, tra Napoli e Capri
Il nome del quartiere Posillipo deriva dal greco Pausilypon, cioè "sollievo da ogni dolore", scelto da Pollione durante il I secolo a.C., come se la bellezza di questo angolo di Napoli fosse un rimedio per i mali dell'anima. Da qui, si può vedere nitidamente l'isola di Capri, in un gioco continuo di sguardi che si intrecciano tra le due località. Un legame che non è solo visivo, ma che racchiude anche una connessione simbolica tra due luoghi la cui bellezza non può che riflettersi l'uno nell'altro.
Queste sono le due location selezionate da Sorrentino per raccontare una parte della città, dove l'incredibile si fa quotidiano e la natura si fonde con l'architettura.
Posillipo, a ridosso del mare, e Capri, l'isola, sono entrambe abitate da architetture che respirano un'atmosfera delicata, come risultato di un'intenzione progettuale che vuole immergersi nel paesaggio circostante.
Se di immersione si parla, però, l'elemento naturale che si impone è l'acqua. Non si tratta solo di una cornice, ma un materiale da costruzione, che spesso diventa un contributo poetico, o ragione stessa di una scelta progettuale.
 Photo of Fabio Scarcella
Photo of Fabio Scarcella
La bellezza materica di Palazzo Donn'Anna
Matilde Serao in "Leggende Napoletane" scriveva: "Il bigio palazzo si erge nel mare. Non è diroccato, ma non fu mai finito; non cade, non cadrà, poiché la forte brezza marina solidifica ed imbruna le muraglie, poiché l'onda del mare non è perfida come quella dei laghi e dei fiumi, assalta ma non corrode». Il bigio palazzo che «mai cadrà» è Palazzo Donn'Anna.
Scavato nel tufo e abbracciato dal mare, il palazzo seicentesco sembra quasi nascere dalle onde stesse del Golfo di Napoli. Il progetto di Cosimo Fanzago, ispirato dalle architetture che si affacciano sul Canal Grande di Venezia, riflette una tensione tra l'incompiuto e l'imponente.
La facciata, realizzata in pietra lavica locale, si distingue per le linee curve e gli angoli acuti, un gioco dinamico tipico del barocco napoletano, che si alternano in un continuo movimento. Le finestre e i balconi con le ringhiere in ferro battuto, contribuiscono a donare un senso di fluidità al prospetto
All'interno, soffitti a volta e a cassettoni in legno, pavimenti in marmo o maiolica con motivi geometrici o floreali, prevalentemente nei toni di blu e giallo, riflettono la ricchezza e la complessità del barocco. Al centro, un cortile circondato da colonne e arcate in tufo collega i vari ambienti, dando un senso di continuità e coesione tra gli spazi.
Il teatro di corte, oggi sede della Fondazione De Felice, non era destinato alle rappresentazioni teatrali tradizionali, ma più a un uso esclusivo per ospiti e proprietari. Ricavato direttamente nel banco tufaceo, il teatro si sviluppa come una galleria sospesa a picco sul mare.
Ma chi era Donna Anna? Anna Carafa della Stadera è stata la proprietaria esclusiva del palazzo a cui diede il suo stesso nome, e che il popolo napoletano confuse con Giovanna II D'Angiò, la regina cui erroneamente il popolo napoletano attribuiva la residenza nobiliare.

Palazzo Donn'Anna © Photo Courtesy of Francesco Mojo

Armando Mancini, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
Villa Rocca Matilde, la villa di delizia dell'armatore Achille Lauro
Un tempo il termine villeggiare era inteso come passare le giornate nelle ville di delizia, luoghi in cui rigenerarsi fisicamente e spiritualmente. La villeggiatura, soprattutto nel periodo aragonese, riacquistò l'antico significato greco e romano del vivere in locus amoenus, cioè di ri-equilibrio tra mente e corpo, immersi nella natura e isolati dal caos della vita quotidiana.
È probabile che anche l'armatore Achille Lauro abbia pensato a questo quando scelse di acquistare Villa Rocca Matilde, che poi prenderà il suo nome. Nel cuore di Posillipo, è stato un luogo da sogno, circondato da storie e leggende, tra cui quelle che narrano i soggiorni di Giuseppe Garibaldi e Giosuè Carducci.
Villa Lauro è caratterizzata da un'imponente facciata neoclassica, con dettagli decorativi, come colonne e balconi, che richiamano il linguaggio dell'architettura dell'epoca. A picco sul blu, grandi archi di mattone e piperno sorreggono un avancorpo a terrazza. La loro disposizione incornicia la vista sul golfo e sul panorama di Posillipo, trasformando la balconata in un vero e proprio luogo di contemplazione.
Nonostante le modifiche subite nel corso degli anni, gli interni mantengono ancora oggi un carattere che richiama l'originalità del progetto. Le stanze hanno soffitti alti con stucchi e affreschi, mentre le pareti sono decorate con boiserie in legno. La disposizione degli spazi, pensata per accogliere tanto la vita quotidiana quanto i grandi eventi sociali, crea un flusso continuo, che permette di muoversi liberamente tra gli ambienti.

Villa Lauro © Photo Courtesy of Francesco Mojo

Villa Lauro | Google Earth
Villa La Pagoda e le pescherie in tufo
A Posillipo, la stratificazione della memoria è densa e porosa proprio come il tufo. Qui, più che in ogni altro luogo, si conserva la storia delle antiche grotte sulle quali i romani vollero realizzare le loro residenze aristocratiche.
Villa La Pagoda sorge proprio sulle grotte scavate nel tufo: tanti sono i reperti archeologici trovati nell'area che testimoniano la presenza di costruzioni di epoca romana. Nel 1814 fu costruita per volere del duca Nicola Caracciolo, tra Palazzo Donn'Anna e Piazza San Luigi. Appassionato di scienze naturali, realizzò un vero e proprio orto botanico con piante esotiche di ogni genere e un piccolo zoo.
La pagoda a più piani, che ricorda una struttura orientale, doveva servire come casino di caccia per gli uccelli migratori, mentre oggi è stata totalmente trasformata in abitazione, in cerca di un compratore da anni. Un tempo, alla parte più alta dell'edificio si accedeva attraverso una scala a chiocciola che si avvolgeva al tronco di un albero.
La discesa a mare, attraverso le grotte romane, giunge fino a una piscina di acqua naturale con attracco privato, che permette di raggiungere la villa direttamente dal mare.

Villa La Pagoda di Posillipo © Photo Courtesy of Francesco Mojo

Villa La Pagoda © Photo Courtesy of Francesco Mojo
La bellezza ordinata dei Giardini di Augusto
A Parthenope basta una notte sull'isola di Capri per scoprire il potere della sua bellezza. I Giardini di Augusto, scelti dal regista per il loro significato, rappresentano il contrasto tra la bellezza naturale e il contesto urbano, simboleggiando la tensione tra l'estetica della vita e la durezza della realtà.
Inizialmente conosciuti come i Giardini di Krupp (dal nome dell'industriale tedesco che ne avviò la costruzione), ancora oggi sono il parco cittadino di Capri. Sono stati poi rinominati Giardini d'Augusto in onore dell'imperatore romano, che apprezzava la bellezza della natura e il legame dell'isola con essa.
Il parco, progettato nel XX secolo per Ferdinand von Pölnitz, si trova in cima a una scogliera, da cui si ammira la baia di Marina Piccola. Terrazze in pietra, scalinate e muretti delineano l'area, accompagnati da piante che decorano in modo naturale ma ordinato, quasi come se la natura stessa fosse stata "modificata" per integrarsi nell'arte della costruzione.
In un certo senso, l'architettura dei Giardini di Augusto è un'interpretazione della "bellezza ordinata", che rispetta il paesaggio naturale senza cercare di sopraffarlo. È un luogo dove la mano dell'uomo si è adattata al contesto, senza mai dominarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: