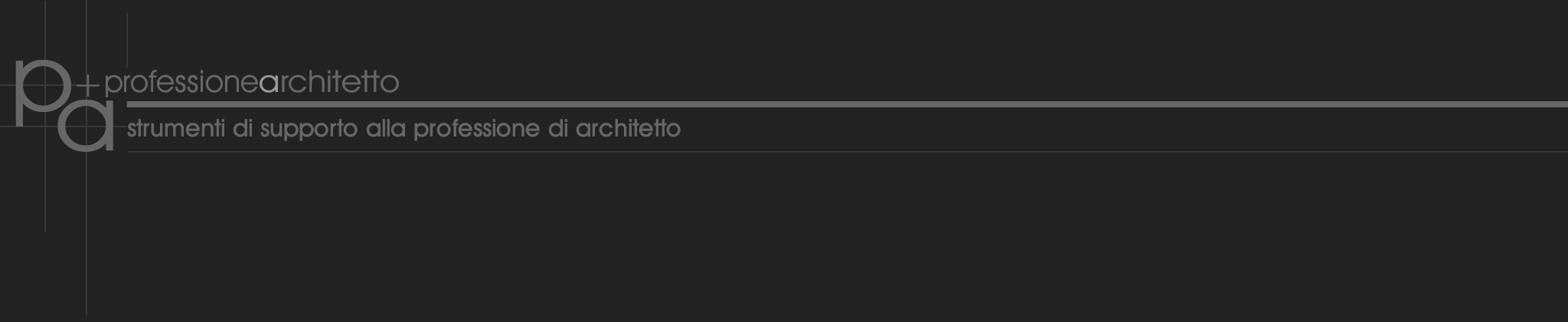Semplificare le agevolazioni edilizie facendole rientrare in un testo unico che racchiuda le regole da rispettare e gli adempimenti a carico di chi intende ristrutturare, efficientare o rendere più sicuro un edificio o un'unità immobiliare. Definire un quadro stabile degli sgravi per assicurare sostenibilità nel tempo agli investimenti e tutelare l'affidamento di famiglie e operatori economici. E poi una razionalizzazione degli incentivi e una rimodulazione delle aliquote che preveda sempre una compartecipazione dell'utente (al contrario di quanto avvenuto col Superbonus) e tenga conto di più fattori: del carattere energivoro degli edifici, del miglioramento conseguito in termini di minor consumo di energia e di risparmio di energia primaria fossile, prevedendo anche trasferimenti diretti per non escludere gli incapienti e le persone in condizione di povertà energetica.
Sono alcuni dei punti che il Parlamento individua per la revisione dei bonus fiscali per l'edilizia, messi nero su bianco nella relazione finale dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia approvata mercoledì 19 marzo in commissione Ambiente alla Camera.
La commissione ha voluto valutare, con un'indagine partita nel 2023, l'efficacia degli incentivi in relazione al raggiungimento degli obiettivi climatici, al risparmio energetico, alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, nonché alla messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio, anche alla luce dell'evoluzione della normativa europea in materia di prestazioni energetiche degli edifici per il raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni del parco immobiliare entro il 2050.
Il governo è tenuto a prevedere una riforma degli incentivi, lo chiede anche la delega fiscale (legge 111 del 2023) per centrare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia. Anche Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), aggiornato al 2024, prevede l'attuazione di una riforma del sistema delle detrazioni con una modulazione dei benefici agganciata alle performance raggiunte dall'edificio. Una riforma che dovrà avere una durata almeno decennale ed essere indirizzata soprattutto alle unità immobiliari soggette alla direttiva "Case green" (direttiva 1275 del 2024).
Il Parlamento traccia una strada, chiedendo anche che il sistema di incentivi sia ripensato per rispondere agli obiettivi climatici, di risparmio energetico, di promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili. Un sistema che deve essere strettamente connesso con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) e basilare per implementare le politiche di decarbonizzazione. In questo senso, va il suggerimento di valutare anche l'utilizzo di criteri che si concentrino sul livello di emissioni risparmiato per metro quadrato.
Va ricordato che la direttiva "Case Green" prevede per gli edifici residenziali una riduzione del consumo medio di energia primaria del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035 insieme all'efficientamento del 16% degli edifici con le prestazioni peggiori entro il 2030 ed il 26% entro il 2033.
Come ricordato nel report «La direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di redigere, entro il 29 maggio 2026, un piano nazionale di ristrutturazione edilizia allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero. Il Piano deve includere una tabella di marcia che comprende obiettivi nazionali al 2030, al 2040 e al 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra».
Un'altra proposta avanzata dal Parlamento consiste nel guardare gli incentivi in una scala più ampia. «Andrebbe valutata - si legge nella relazione - l'opportunità di riconfigurare il sistema degli incentivi su tessuti edilizi ed urbanistici più ampi, a partire dai condomini, anche al fine di massimizzarne l'impatto ambientale, sociale e di messa in sicurezza e di ricollegarne la funzione a finalità di autoproduzione energetica attraverso le comunità energetiche, e incentivi fiscali per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare o eolica ad uso domestico, nonché per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici». «In tale ambito, le operazioni di demolizione e ricostruzione possono svolgere un ruolo importante per finalità di miglioramento energetico e di rigenerazione urbana».
Inoltre, gli incentivi dovrebbero premiare la qualità degli interventi, l'utilizzo di tecnologie innovative e l'uso di materiali riciclati/riciclabili e sostenibili. E poi «grande importanza dovrebbe continuare a rivestire l'agevolazione di interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui andrebbe valutato in modo più accurato l'impatto e il miglioramento della classe sismica». Bisogna puntare anche sugli edifici pubblici e sull'edilizia residenziale pubblica e sociale, che rivestono un ruolo cruciale nell'ambito del miglioramento dell'efficienza energetica.
Infine, «è essenziale promuovere la qualificazione delle imprese edilizie per garantire trasparenza, affidabilità e sicurezza anche in conformità con le direttive dell'UE sull'efficientamento energetico, considerato che l'aumento del numero delle imprese qualificate migliora la qualità dei lavori e promuove una competizione equa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: